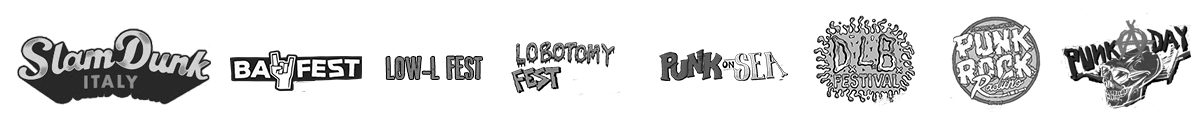La vostra storia è qualcosa che fa ben comprendere cosa significhi amare ciò che si fa: sedici anni di sudata carriera, diversi dischi prodotti e live al fianco di nomi come Misfits, Lagwagon e molti altri. Quindi la prima cosa che mi viene da chiedervi è cosa spinge ancor oggi musicisti ormai adulti a crederci ancora?
Prima di ogni cosa il bisogno di farlo, la voglia di comporre canzoni, di registrarle e di promuoverle dal vivo. Abbiamo tutti vite, lavori e famiglie al di fuori della band, ma la nostra band è la famiglia che con amore abbiamo coltivato nel corso di tutti questi anni. Non riusciamo, davvero, a non suonare insieme se non con quegli obiettivi. Non è un hobby, è la nostra vita, quella che vogliamo portare a termine, sempre. La seconda è che siamo, ancora oggi, soddisfatti di ogni singolo brano che abbiamo registrato sui nostri dischi: quei dischi, quello che rappresentano e la gente che ci ascolta quando suoniamo dal vivo sono la spinta a continuare a farlo. Nonostante l’età che avanza sappiamo di potere dare ancora qualcosa alla musica, e che possiamo altrettanto ricevere.
Da poco siete giunti alla pubblicazione di “Black Foundation”, un titolo tenebroso quasi quanto la cover. Quali sono i suoi intenti e cosa troverà al suo interno l’ascoltatore?
L’intento è quello di tracciare la nostra carta d’identità, oggi. Il disco rappresenta al meglio ciò che siamo diventati, nel corso degli anni trascorsi. Ci sono tutte le nostre esperienze dentro, vissute all’interno della band e al di fuori. Al netto del titolo e della copertina, non è un disco necessariamente oscuro, anzi. E’ multicolore, ogni brano ha un colore diverso: c’è anche il nero, non c’è dubbio, ma non è il solo colore. E’ la summa degli ultimi quattro anni, in cui non siamo rimasti fermi, ma abbiamo vissuto la sala prove fino a quando questa non ci ha restituito il suono che volevamo. I suoni che volevamo. Chi ascolterà il disco, chi lo ha ascoltato sa di trovare un lavoro assolutamente sincero, frutto di ciò che i None Of Us sono oggi.
Rispetto al suo predecessore l’ho trovato molto più “inquadrato” artisticamente, ossia meno sperimentazione ma diretti all’obiettivo. Siete d’accordo con me?
Oggi, di più rispetto ai tempi di “Vita”, siamo più abili nel comporre canzoni. Intro, strofa, ritornello, bridge, chiusura. Non siamo mai stati una band che sperimentava sul suono, o sui suoni: abbiamo sempre cercato una composizione che esaltasse noi, prima dell’ascoltatore. Evidentemente abbiamo un’audience che ci assomiglia molto. Abbiamo, infatti, un pubblico molto fedele che sa cosa proponiamo. Nel registrare il disco abbiamo avuto sin da subito la consapevolezza che fosse il nostro disco più maturo, per alcuni aspetti il migliore. Di certo, quello di cui siamo più soddisfatti.
Altra nota interessante: in passato vi siete affidati a produttori altisonanti (mi viene da citare Kurt Ballou dei Converge), oggi invece avete optato per una gestione diretta del tutto. A cosa dobbiamo questa scelta?
In realtà sia Kurt Ballou (rispetto al nostro primo full-lenght “Further Hangin’ Menace”) che Mike Major (“Vita”) sono entrati nella fase di produzione per mixaggio e mastering: il resto l’abbiamo sempre fatto da soli (per il primo abbiamo avuto lo splendido Frank Andiver come ingegnere del suono). Queste persone hanno fatto sì che i nostri dischi suonassero veri, quasi live, ma senza alcuna imperfezione. Una botta di un certo livello, per capirci. Ma abbiamo sempre saputo prima come dovessero suonare i nostri dischi, anzi, abbiamo sempre saputo come non dovessero suonare. Siamo stati abili a ricreare in studio i suoni che normalmente riusciamo ad avere dal vivo. Oggi ci affidiamo a Giacomo Iannaci, che ha sempre seguito la band, dal vivo come tecnico del suono, in studio come ingegnere e finalmente come chitarrista (ottimo quale è). Abbiamo registrato e mixato presso i suoi Morning View Studio, a Ragalna, in provincia di Catania. Giacomo sa lavorare benissimo e in “Black Foundation” il suo apporto è stato totale, definitivo e determinante.
Cosa si ottiene a vostro avviso nell’avere nomi altisonanti sul disco (dal produttore a un guest)? C’è un effettivo guadagno in tutto ciò? Sinceramente nutro da sempre dubbi in merito eppure sembra una soluzione adottata spessissimo!
Non si ottiene nulla, al nostro livello. Una partnership, in qualunque ambito, produce degli effetti se c’è uno scambio utile, proficuo. Inserire un nome altisonante in un disco di sconosciuti è solo una marchetta che può alzare un po’ le vendite o la possibilità di essere conosciuti. A noi non è mai interessato: ci siamo sempre concentrati di fare al meglio ciò che sappiamo fare. E non abbiamo mai avuto i soldi a sufficienza per le marchette.
La Sicilia non è certo nota per la sua scena alternative, o mi sbaglio?! Come si vive da musicisti da quelle parti?!
Si vive come in ogni altra parte del mondo. Maluccio. Conosco davvero tanti ragazzi che suonano, bene, benissimo ma che si scontrano con una realtà (quella dei locali dove potere proporre musica, per esempio) assolutamente asfittica. Nessuno ha più il coraggio di investire. Anche quando non ci sarebbe bisogno di avere coraggio. Volendo utilizzare una metafora grezza, noi siamo una band “usato sicuro”, dovunque andiamo la gente è sempre numerosa e contenta, lascia il locale sudata e felice. Abbiamo una storia e una credibilità live abbastanza concreta: ciò non di meno non è sempre semplice trovare posti dove esibirci. Dieci anni fa non era così.
Torniamo al disco ossia ai testi, che come dicevo prima sembrano legati a titolo e concept grafico. Volete parlarcene? Con quale mood avete dato il via alle lavorazioni di “Black Foundation”?
Abbiamo cominciato praticamente non appena abbiamo finito di registrare “Vita”: ogni volta che finiamo un disco, abbiamo l’esigenza fisiologica di ricominciare a mettere le basi per qualcos’altro. Davide (voce) era pieno di idee per canzoni nuove e, come sempre accade nel nostro processo compositivo, le ha fatte ascoltare a me (Filippo, chitarra): da lì, pian piano, sono diventate della band, ma non ci siamo fermati fino a quando non siamo stati contattati da Beppe Platania, boss di This Is Core Records, che voleva produrci. A quel punto abbiamo deciso che era arrivato il momento di entrare in studio, cosa che avremmo fatto comunque, anche senza etichetta, perché sapevamo quale fosse il valore del disco. E’ stato tutto naturale e spontaneo, come sempre. La nostra cartina di tornasole rispetto al disco è “12 o’clock high” la cover dei Dirty Looks che abbiamo inserito nell’album: non ci siamo fermati fino a quando non suonava come noi, spontanea. Molti arrangiamenti di chitarra sono stati pensati e composti davanti al banco di missaggio: alcune cose sono state improvvisate e fissate al primo take. E’ stato meraviglioso, ma stressante. Avevamo tempi contingentati e la pressione era moltissima. Ne siamo usciti a testa alta e lo stress è un prezzo che paghi con piacere, se l’effetto è questo. Il concept è nato del tutto spontaneamente, la cover, come le foto del booklet sono opera di un giovane “artista” catanese, Alberto Mantegna, bassista sopraffino, ottimo amico e ho scoperto del tutto casualmente, ottimo fotografo. Avevamo deciso di affidarci a lui solo per le foto della band e non avevamo assolutamente idea di quale potesse essere la copertina: avevamo solo il titolo dell’album. Che nacque di notte, scherzando con Davide, via mail. Mi aveva proposto dei titoli vergognosi, roba da prima elementare. Però servirono a farmi pensare a come non doveva essere il titolo e me ne allontanai, concettualmente. Fu allora che pensai che il titolo dovesse avere a che fare con una donna, al trucco di una donna. Pensai al fondotinta, “Foundation”. “Black” venne consequenzialmente. Davide approvò subito, come il resto della band. Era fatta. La copertina doveva avere un viso di donna, nel nostro caso quello splendidamente evocativo di Giuliana Lantino, attrice e nostra amica: mentre scattava le foto, Alberto pensò alla cenere vulcanica e nel giro di una settimana Giuliana era ricoperta da cenere vera. Il suo “fondotinta nero” è la radice da cui noi veniamo, la nostra terra, quella più nascosta e pericolosa, però bellissima.
Il fatto di esservi preso qualche anno di pausa tra il passato lavoro e quest’ultimo a cosa è dovuto?!
Abbiamo vissuto, lottato e resistito: tutto ciò che puoi sentire nell’album.
Quali dischi hanno influito nella crescita artistica dei None Of Us?
Due tipi di dischi: quelli che ascoltiamo (le nostre influenze sono moltissime, se devo citarti qualche nome, ti dico Deftones, The Mars Volta, Prince, Ministri, Linea 77 e Sigur Ros) e quelli che abbiamo pubblicato. Siamo partiti da noi per arrivare a noi.
Cosa vi piace maggiormente del vostro progetto?
La spontaneità: ci diciamo sempre che smetteremo quando non avremo più nulla di credibile da dire. Quel momento credo che non sia ancora arrivato.
Qual è stato il punto più alto raggiunto dalla band a vostro avviso?
Potrei dirti che deve ancora arrivare ed è così, ma il nostro primo tour italiano (2004/2005) e il tour in Gran Bretagna (2007) di certo sono stati momenti di svolta per noi. Lì abbiamo capito che potevamo fare qualcosa in questo campo.
Cosa state ascoltando oggigiorno?!
“Black Foundation”, in loop.